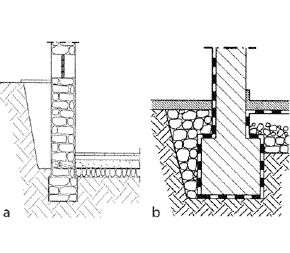Armature di fondazioni.
La vastità della problematica affrontata è stata, nel corso dei millenni, risolta con una risposta tipologica ampia ed articolata.Abbiamo provato a creare un quadro sinottico delle costruzioni a contatto con il terreno. Successivamente passeremo in rassegna le tipologie più utilizzate.
LA SCELTA DELLA FONDAZIONE
La scelta di una fondazione è legata, a tre parametri essenziali:
la forma del carico da sopportare (puntiforme, lineare, superficiale);
l’entità del carico da sopportare (piccola, media, alta);
la capacità portante del terreno (scarsa, normale, buona, ottima).
CORDOLO
Quando la portanza del terreno è normale, la fondazione può essere a diretto contatto con il terreno.
Se l’entità dei carichi e la dimensione dell’edificio non è eccessiva, possiamo ricorrere a fondazioni di calcestruzzo non armato.
Se la struttura portante dell’edificio è a muri portanti, cioè lineare, si deve fare riferimento a una fondazione continua.
La più semplice delle fondazioni continue è il cordolo, che può essere semplice o a risega.
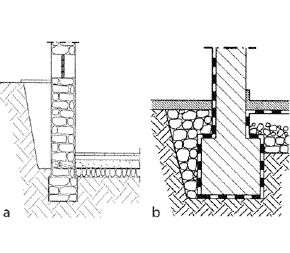 |
| Cordoli di fondazione in calcestruzzo non armato, semplice e a risega. Si tratta della più semplice tipologia di fondazione continua. È adatta per piccoli edifici e terreni con discreta capacità portante. |
FONDAZIONE DISCONTINUA
Se la struttura portante dell’edificio è a pilastri, cioè puntiforme, si deve fare riferimento ad una fondazione discontinua (o isolata).
PLINTO NON ARMATO
La più semplice delle fondazioni discontinue è il plinto non armato (inerte)
Cordolo armato.
CORDOLO ARMATO SAGOMATO
Quando l’entità dei carichi dell’edificio cresce, nelle fondazioni, occorre passare all’uso del cemento armato.
Se il carico è lineare, ma ingente occorre utilizzare una fondazione continua armata.
La tipologia più semplice, in questo caso, è quella del cordolo armato.
Fondazione a trave rovescia armata.
TRAVE ROVESCIA ARMATA
Se l’utilità dei carichi del muro portante è molto elevata, oppure ci troviamo di fronte ad un terreno con bassa portanza e carichi puntiformi elevati, si può ricorre ad una trave rovescia armata.
ARCO ROVESCIO
E’ questa la risposta moderna (posteriore alla scoperta del cemento armato) di una soluzione antica, quella della fondazione ad arco rovescio.
FONDAZIONE DISCONTINUA ARMATA
In caso di carico puntiforme, ma ingente, possiamo ricorrere ad una fondazione discontinua armata.
PLINTO
La tipologia fondamentale, che è anche, in assoluto, la più utilizzata, è quella del plinto.
Ne esistono di diverse categorie:
- plinto basso;
- plinto alto;
- plinto nervato;
- plinto zoppo;
- plinto a tappo.
L’unione di più plinti crea una fondazione a zattera.
PLATEA
Quando le condizioni statiche del terreno sono molto modeste, si ricorre ad una grande soletta di fondazione: la platea.
Esistono due diverse tipologie di platee, in base al criterio di armatura:
- platea priva di alleggerimenti;
platea nervata.
FONDAZIONI INDIRETTE
Quando le cattive caratteristiche statiche del terreno non permettono l’utilizzo di fondazioni dirette, occorre procedere, tramite pali, a fondazioni indirette.
PALI
Le fondazioni indirette sono costituite da pali, che possono essere realizzati con due diverse metodologie:
palo battuto
- in legno;
- in acciaio;
- in cemento armato;
palo trivellato;
- palo Franki;
- palo Simplex;
- palo Benato;
- palo alla bentonite.
PLINTO SU PALI
Se la capacità portante di un solo palo non è sufficiente, le teste di più pali debbono essere unite con una soletta, che funge, praticamente, da plinto su pali.
Le tipologie di collegamento più usate sono:
a due pali;
a tre pali;
a quattro pali.